Le competenze informatiche sono essenziali
Solitamente ormai si danno per scontate, ma le abilità nell’utilizzo del pc non sono un patrimonio comune. E, soprattutto, bisogna intendersi su che cosa significhi oggi sapere e potere utilizzare in maniera adeguata un computer. Se leggete questo post, quantomeno avete la padronanza minima della navigazione in internet e siete arrivati in qualche maniera a visualizzare queste righe. In Italia questa capacità non ce l’hanno tutti ed il problema non è tanto e solo di spendibilità nel mercato del lavoro ma anche di accesso alle opportunità. Significa che chi non sa utilizzare un computer non solo ha meno possibilità di trovare un lavoro dignitoso ma già oggi non è nella condizione di poter fare alcun lavoro.
Per dare un’idea un po’ più precisa di quello che accade oggi in Italia, riprendiamo da un articolo del giornale on line Linkiesta alcuni dati relativi alla diffusione di internet nel nostro Paese. Il dibattito italiano, solitamente, si ferma alla poca diffusione della banda larga nelle case degli italiani. Questa mancanza si porta dietro anche una serie di correlazioni e conseguenze, non ultima quella delle poche opportunità che ci sono di progredire in tema di diffusione della cultura informatica nella popolazione. In sostanza il pensiero è che siccome le infrastrutture esistenti sono poco sviluppate, ne consegue che sono poche anche le persone che le sanno utilizzare. Sicuramente questo è un dato veritiero, sostenuto anche da ricerche ed analisi di carattere scientifico. Per farci meglio capire, è come se dicessimo che in un dato luogo non ci va nessuno perché non c’è nessuna strada o collegamento che lo raggiunge.
Per l’informatica vale la pena però prendere in considerazione anche un altro fattore, se non altro per rifuggire da un atteggiamento attendista che è un po’ tipico italiano (della serie: non utilizzo il pc/web fintanto che non c’è una struttura adatta). In questo senso un dato che noi definiamo allarmante è quello che indica che a fronte di un aumento delle connessioni in banda larga di circa quaranta punti percentuali in meno di dieci anni, le abilità informatiche della popolazione italiana sono rimaste sostanzialmente al palo. Se è vero che il web veloce facilita l’accesso e l’utilizzo questo non dovrebbe accadere. Forse potrebbe essere utile un po’ di istruzione? Magari l’utilizzo e l’acquisizione di competenze informatiche cresce anche grazie a processi in cui si cerca di alfabetizzare le persone che dovranno utilizzarlo.
Sempre Linkiesta riporta che “l’implementazione di politiche per la diminuzione dell’analfabetismo informatico potrebbe essere una buona leva per far crescere il mercato delle vendite online, perlomeno in relazione all’Italia. Un Paese, forse vale la pena di ricordarlo, in cui il 39% della popolazione non ha mai navigato su internet. L’esempio da seguire, in quest’ambito, è quello dei paesi scandinavi”. Insomma sarebbe necessario tornare un po’ sui “banchi” o, meglio, sui PC di scuola per imparare ad utilizzare il computer. L’alfabetizzazione digitale, come viene chiamata, aiuterebbe non soltanto a far progredire il singolo, ma anche l’intera comunità in termini di ricchezza di opportunità, sviluppo di nuovi mercati, consapevolezza e cultura generale. Insomma, un vero progresso. Che stiamo aspettando?
Nel nostro piccolo, niente! Infatti certi che questa cosa fosse utile abbiamo fatto partire qualche tempo fa il minicorso “ABC per il PC” che in tre moduli insegna a chi proprio non ne sa nulla che cosa fa e a che cosa serve il computer. Ci piace dirlo: è stato un successone! Talmente elevato che abbiamo deciso di riaprire le iscrizioni. Se conoscete qualcuno che non saprebbe raggiungere questo articolo per leggerlo è il momento giusto per fargli un regalo: ditegli di iscriversi ad ABC per il PC, lo aspettiamo!










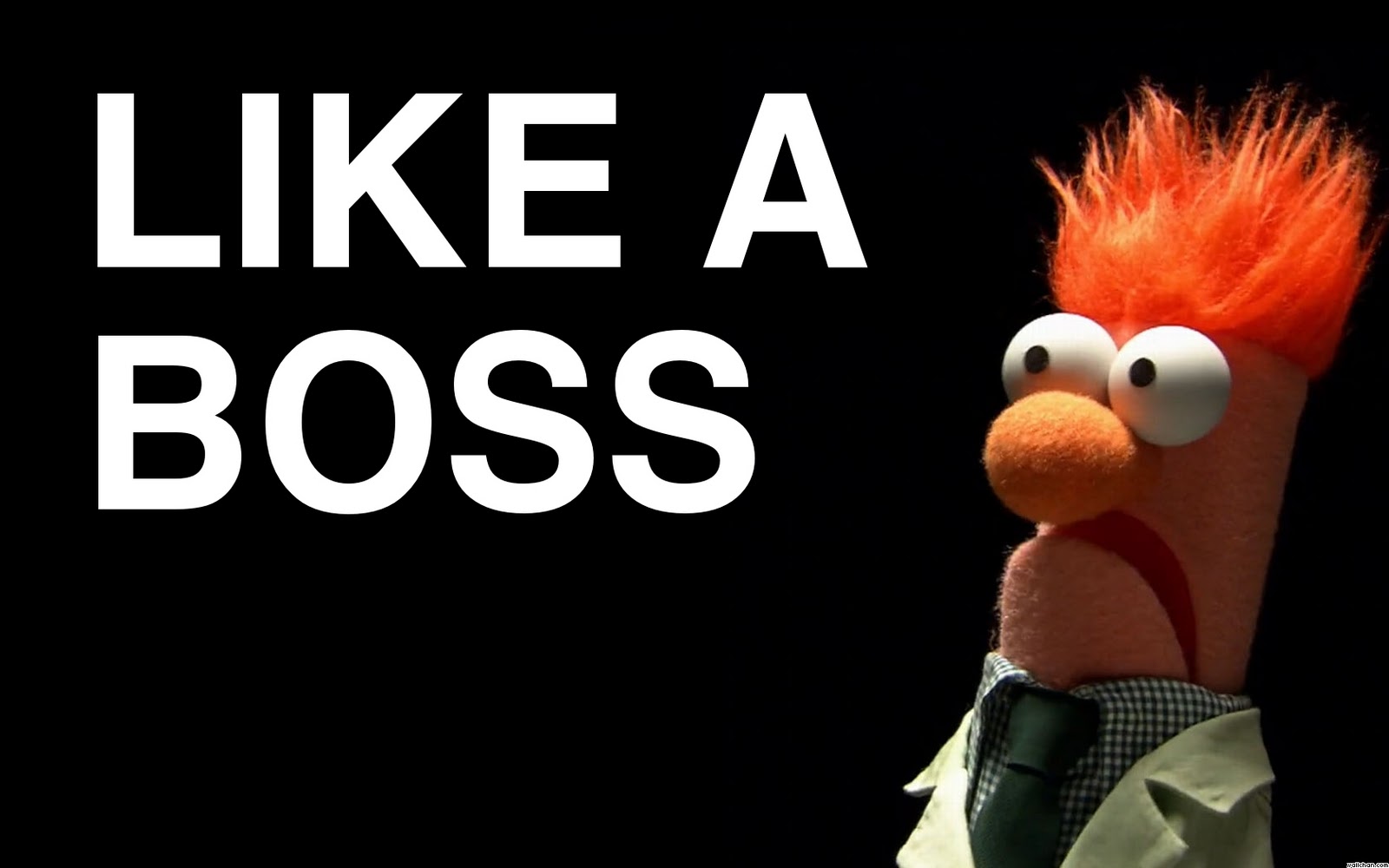


 Benvenuti! O, meglio, bentornati e benritrovati! Finalmente torna ad aggiornarsi il nostro spazio web che, dopo l’estate, ha fatto un po’ di lifting ;-). Come vedete, ha una faccia nuova! Abbiamo una nuova veste grafica ma non solo. Non ci siamo scostati troppo dalla precedente versione soprattutto per non creare troppo scompiglio e confusione (immaginavamo già mail e telefonate alla richiesta di chiarimenti su dove fossero finiti gli elenchi dei corsi o le offerte di lavoro; ah, presto anche queste avranno uno spazio tutto loro).
Benvenuti! O, meglio, bentornati e benritrovati! Finalmente torna ad aggiornarsi il nostro spazio web che, dopo l’estate, ha fatto un po’ di lifting ;-). Come vedete, ha una faccia nuova! Abbiamo una nuova veste grafica ma non solo. Non ci siamo scostati troppo dalla precedente versione soprattutto per non creare troppo scompiglio e confusione (immaginavamo già mail e telefonate alla richiesta di chiarimenti su dove fossero finiti gli elenchi dei corsi o le offerte di lavoro; ah, presto anche queste avranno uno spazio tutto loro).
 Considerato il tempo e la data oggi parliamo di vacanze. Ora qualcuno si immaginerà, giustamente, che tratteremo di mete in paesi esotici, di arrampicate sui monti o di bagni in mezzo a piscine naturali piene di pesci. Ma su questi temi non siamo molto ferrati e, al massimo, potremmo riportare soltanto qualche piccola esperienza personale di poco conto. Invece scriviamo di vacanze perché la notizia è che le vacanze ci rendono più produttivi e ci aiutano anche a essere più efficaci nelle nostre mansioni professionali.
Considerato il tempo e la data oggi parliamo di vacanze. Ora qualcuno si immaginerà, giustamente, che tratteremo di mete in paesi esotici, di arrampicate sui monti o di bagni in mezzo a piscine naturali piene di pesci. Ma su questi temi non siamo molto ferrati e, al massimo, potremmo riportare soltanto qualche piccola esperienza personale di poco conto. Invece scriviamo di vacanze perché la notizia è che le vacanze ci rendono più produttivi e ci aiutano anche a essere più efficaci nelle nostre mansioni professionali.
 Come si fa a farsi venire un’idea? Così, in maniera astratta e non contestualizzata, forse è davvero difficile non solo spiegarlo ma anche riuscirci. In realtà le idee nascono anche un po’ per caso, per un sogno o un desiderio, perché leggiamo una frase che ci appassiona o vediamo qualcosa che ci colpisce. La famosa lampadina che si accende, insomma, non è sempre pronta a rispondere ai nostri comandi e talvolta, anche se lo vogliamo, le idee non vengono. Per questo motivo negli anni ’40 del secolo scorso, un pubblicitario americano di nome Alex Osborn, aveva inventato un metodo per far nascere le idee: l’ormai conosciuto, diffuso e strausato brainstorming.
Come si fa a farsi venire un’idea? Così, in maniera astratta e non contestualizzata, forse è davvero difficile non solo spiegarlo ma anche riuscirci. In realtà le idee nascono anche un po’ per caso, per un sogno o un desiderio, perché leggiamo una frase che ci appassiona o vediamo qualcosa che ci colpisce. La famosa lampadina che si accende, insomma, non è sempre pronta a rispondere ai nostri comandi e talvolta, anche se lo vogliamo, le idee non vengono. Per questo motivo negli anni ’40 del secolo scorso, un pubblicitario americano di nome Alex Osborn, aveva inventato un metodo per far nascere le idee: l’ormai conosciuto, diffuso e strausato brainstorming.
 Questa avventura è nata nel giorno in cui la mia professoressa mi ha comunicato che avrei fatto le mie tre settimane di alternanza scuola-lavoro all’Informagiovani: non conoscevo molto questo servizio, anzi le mie informazioni erano veramente scarse.
Questa avventura è nata nel giorno in cui la mia professoressa mi ha comunicato che avrei fatto le mie tre settimane di alternanza scuola-lavoro all’Informagiovani: non conoscevo molto questo servizio, anzi le mie informazioni erano veramente scarse.
 Torniamo spesso a parlare di competenze e conoscenze, fondamento di una solida vita professionale (e se volete anche personale). Quante cose conosciamo? E quante ne conosciamo abbastanza bene da poter essere considerati dei “maestri” in quella materia? L’importanza di questo aspetto è fondamentale: soprattutto in ambito lavorativo (e non solo se faremo i maestri o i professori in futuro). Per definire meglio quello di cui vogliamo parlare vi raccontiamo una storiella.
Torniamo spesso a parlare di competenze e conoscenze, fondamento di una solida vita professionale (e se volete anche personale). Quante cose conosciamo? E quante ne conosciamo abbastanza bene da poter essere considerati dei “maestri” in quella materia? L’importanza di questo aspetto è fondamentale: soprattutto in ambito lavorativo (e non solo se faremo i maestri o i professori in futuro). Per definire meglio quello di cui vogliamo parlare vi raccontiamo una storiella.

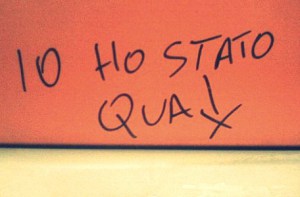
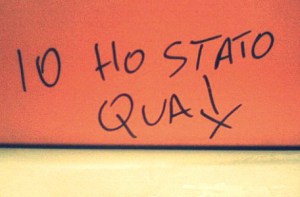 Rimaniamo sul tema del
Rimaniamo sul tema del 
 Di solito si dice che abbiamo sempre una seconda occasione: giusto, non sembra nemmeno a noi utile affermare il contrario. Di fatto è anche il momento in cui impariamo qualcosa, perché la “seconda volta” è l’occasione in cui abbiamo avuto già un’esperienza e siamo in grado di poterla mettere a frutto, migliorando quello che abbiamo fatto bene ed evitando gli errori già commessi. Nonostante questo nella vita ci sono casi in cui questa seconda possibilità non ce l’abbiamo:
Di solito si dice che abbiamo sempre una seconda occasione: giusto, non sembra nemmeno a noi utile affermare il contrario. Di fatto è anche il momento in cui impariamo qualcosa, perché la “seconda volta” è l’occasione in cui abbiamo avuto già un’esperienza e siamo in grado di poterla mettere a frutto, migliorando quello che abbiamo fatto bene ed evitando gli errori già commessi. Nonostante questo nella vita ci sono casi in cui questa seconda possibilità non ce l’abbiamo: