Imparare ad imparare

Boy reading book
Che siate ancora studenti oppure già immersi nel mondo del lavoro, ci sembra evidente che il detto “nella vita non si finisce mai di imparare” sia quantomai attuale. Oggi non si può smettere di imparare cose nuove, nella vita e nella professione. Per due motivi fondamentali. Il primo è che l’evoluzione che stiamo vivendo in questa epoca ci presenta ogni giorno una novità: nel tempo abbiamo imparato a organizzare viaggi da soli con internet, a comunicare senza telefonare con un telefono (paradossale), a monitorare digitalmente quello che facciamo durante la giornata. Il secondo motivo per non smettere mai di imparare è che il mondo in cui viviamo, che lo vogliamo o meno, è davvero molto competitivo. Significa che se non siamo aggiornati, sempre, rischiamo di rimanere esclusi dalle opportunità che si presentano.
La notizia buona è che esiste un metodo per riuscire ad imparare: alcuni scienziati americani hanno scoperto 10 segreti per imparare. Alcuni faranno particolarmente piacere agli studenti, altri un po’ meno. Vediamo quali sono. Il primo è esistono i tempi giusti per imparare: non tutti i momenti della giornata sono uguali per il nostro sistema cognitivo. Per esempio le persone più adulte (se non addirittura anziane) riescono ad apprendere meglio la mattina; così come gli studi hanno evidenziato che è meglio studiare le lingue il pomeriggio e che andare a dormire subito dopo aver studiato qualcosa aiuta a consolidare l’apprendimento. Studiate e interrogatevi: il nostro cervello quando viene messo alla prova restituisce il meglio di sè (ragazzi, è per questo che a scuola ci sono le interrogazioni!). La cosa funziona anche se ci interroghiamo da soli: per cui una buona tecnica è quella di leggere qualcosa e poi chiedersi che cosa abbiamo letto, sforzandoci di ricordare temi, collegamenti, idee appena apprese. Distrarsi non è un peccato, a patto che la distrazione non coinvolga le stese funzioni cognitive che state utilizzando per imparare. Per esempio gli odori associati ad una lettura renderanno quella lettura indimenticabile ogni qualvolta percepirete lo stesso odore. Chiaramente la cosa non funziona altrettanto bene, anzi è deleteria, se a distrarvi sono WhatsApp, sms o post su Facebook. Esiste anche l’apprendimento passivo: possiamo imparare qualcosa anche mentre stiamo facendo dell’altro; se guardiamo un film in lingua riusciamo a seguire la trama e i suoi protagonisti ma al contempo a immagazzinare vocaboli che non conosciamo (e che ci rimarranno in mente!). Il team facilita l’apprendimento, soprattutto in una fase successiva allo studio da soli. Il gruppo di studio, per essere efficace, deve svolgere due attività: discussione e risoluzione dei problemi.
Bella notizia per i più giovani: i videogiochi sono un toccasana per l’apprendimento! Pare infatti che l’abilità che si sviluppa nella pratica di un videogioco, soprattutto se di azione, accelera la capacità del cervello di formare precisi modelli di coordinazione occhio-mano che aiutano l’efficienza generale della nostra mente nell’apprendere. Spesso ne sentiamo il bisogno, ma a questo punto possiamo dire che un periodo di relax è un dovere se vogliamo che le cose che impariamo possano sedimentarsi nella nostra memoria. Una pausa dedicata al rilassamento può consistere in un pisolino oppure in una partita dello sport che preferiamo: l’importante è che il corpo, oltre la mente, abbia la possibilità di rigenerarsi in qualche modo. Vi siete mai chiesti perché state imparando qualcosa? Bene, da oggi la risposta, vera o falsa che sia, può essere questa: “devo insegnare”. Fingere di essere degli insegnanti che devono riproporre i concetti che hanno studiato è un utile esercizio che migliora le nostre capacità cognitive (badate bene che se andate ancora a scuola la finzione deve necessariamente finire all’ingresso 😉 ). Scegliete bene i tempi: se oggi studio qualcosa non è detto che ripeterlo o ripassarlo immediatamente. Il nostro cervello è programmato per ricordare le cose in tempi che non sono casuali: c’è un nesso temporale preciso tra il momento in cui impariamo qualcosa e quello in cui dovremo utilizzarlo. Se per esempio volete ricordare qualcosa tra un anno, dovete ripassarlo un mese dopo averlo imparato e poi una volta al mese fino alla fine dell’anno. La nostra memoria e la nostra capacità di apprendere si comportano essenzialmente come dei muscoli: più li esercitiamo e più saranno reattivi nella risposta. Per questo è importante non abbandonare lo studio anche quando scarseggiano i risultati: in questo senso sapersi perdonare un fallimento (un corso non andato bene, un brutto voto ad una interrogazione, un esame saltato)a patto che non sia un’abitudine, ci libera da pensieri negativi e rafforza la nostre prestazioni future.
Ora che sapete come fare non vi rimane che imparare! 😉





 La signora Rita era un’insegnante di pianoforte. E anche una riconosciuta musicista che teneva concerti. Era anche una professoressa premiata per la sua attività didattica. Nella vita privata era una attivista per i diritti civili, soprattutto nella zona in cui viveva. Era anche una scrittrice, con tre libri dedicati ad un pianista famoso. Era anche la direttrice di una scuola di musica ed un membro di una giuria di un concorso musicale per una decina di anni. Quando la signora Rita morì se aveste chiesto ad uno dei suoi studenti chi fosse la signora Rita, questi vi avrebbe risposo semplicemente “la mia insegnante di piano”; se lo aveste chiesto ad uno dei lettori dei suoi libri vi avrebbe risposto “l’autrice del libro…”. E infine alla stessa domanda i suoi amici avrebbero risposto “una simpatica amica che suonava il piano”.
La signora Rita era un’insegnante di pianoforte. E anche una riconosciuta musicista che teneva concerti. Era anche una professoressa premiata per la sua attività didattica. Nella vita privata era una attivista per i diritti civili, soprattutto nella zona in cui viveva. Era anche una scrittrice, con tre libri dedicati ad un pianista famoso. Era anche la direttrice di una scuola di musica ed un membro di una giuria di un concorso musicale per una decina di anni. Quando la signora Rita morì se aveste chiesto ad uno dei suoi studenti chi fosse la signora Rita, questi vi avrebbe risposo semplicemente “la mia insegnante di piano”; se lo aveste chiesto ad uno dei lettori dei suoi libri vi avrebbe risposto “l’autrice del libro…”. E infine alla stessa domanda i suoi amici avrebbero risposto “una simpatica amica che suonava il piano”.
 Una delle cose che fa l’Informagiovani, oramai si è detto un sacco di volte, è orientare le persone. Che cosa vuol dire nello specifico? Tradotto nella pratica vuol dire molte cose. Per esempio significa in un servizio come il nostro se fai una domanda la risposta che ricevi potrebbe non essere solo quella che cercavi, perché cerchiamo di capir se stai cercando davvero quello che fa per te (e per scoprirlo spesso ad una domanda tocca rispondere con un’altra domanda).
Una delle cose che fa l’Informagiovani, oramai si è detto un sacco di volte, è orientare le persone. Che cosa vuol dire nello specifico? Tradotto nella pratica vuol dire molte cose. Per esempio significa in un servizio come il nostro se fai una domanda la risposta che ricevi potrebbe non essere solo quella che cercavi, perché cerchiamo di capir se stai cercando davvero quello che fa per te (e per scoprirlo spesso ad una domanda tocca rispondere con un’altra domanda).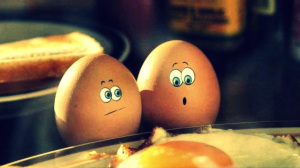
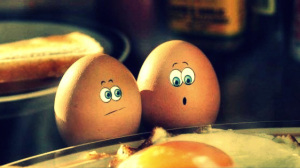 Al supermercato ci avviciniamo alla corsia dove dobbiamo prendere i biscotti per la colazione e troviamo subito i nostri preferiti: la busta gialla lì davanti a noi contiene i nostri preferiti, quelli che avevamo proprio voglia di addentare la mattina appena svegli. Li abbiamo scelti perché sono croccanti al punto giusto, ci saziano senza appesantirci, rispettano la nostra dieta ma anche al nostra fame. Insomma, sono quasi perfetti e siamo felici della nostra scelta. L’abbiamo fatta davvero noi? Quei biscotti stanno in quel posto nel supermercato non per puro caso o perché l’abbinamento dei colori delle confezioni suggeriva quella posizione. Il motivo per cui stanno lì è dovuto ad un processo in cui si mischiano marketing, pubblicità, gestione del magazzino e delle vendite, promozioni, accordi commerciali e qualche trucco. Insomma forse quella scelta non l’abbiamo fatta proprio noi: sfruttando il nostro inconscio qualcuno è riuscito a “darci le giuste indicazioni” per arrivare a quella scelta. Un esempio ulteriore, sempre da supermercato: caramelle, gomme da masticare e mentine si trovano in grande abbondanza vicino alle casse. Non solo perché si dice siano “acquisti di impulso” ma anche perché se andaste a vedere il loro costo effettivo prendendovi qualche istante in più (che solitamente alle casse non avete) scoprireste che le mentine potrebbero
Al supermercato ci avviciniamo alla corsia dove dobbiamo prendere i biscotti per la colazione e troviamo subito i nostri preferiti: la busta gialla lì davanti a noi contiene i nostri preferiti, quelli che avevamo proprio voglia di addentare la mattina appena svegli. Li abbiamo scelti perché sono croccanti al punto giusto, ci saziano senza appesantirci, rispettano la nostra dieta ma anche al nostra fame. Insomma, sono quasi perfetti e siamo felici della nostra scelta. L’abbiamo fatta davvero noi? Quei biscotti stanno in quel posto nel supermercato non per puro caso o perché l’abbinamento dei colori delle confezioni suggeriva quella posizione. Il motivo per cui stanno lì è dovuto ad un processo in cui si mischiano marketing, pubblicità, gestione del magazzino e delle vendite, promozioni, accordi commerciali e qualche trucco. Insomma forse quella scelta non l’abbiamo fatta proprio noi: sfruttando il nostro inconscio qualcuno è riuscito a “darci le giuste indicazioni” per arrivare a quella scelta. Un esempio ulteriore, sempre da supermercato: caramelle, gomme da masticare e mentine si trovano in grande abbondanza vicino alle casse. Non solo perché si dice siano “acquisti di impulso” ma anche perché se andaste a vedere il loro costo effettivo prendendovi qualche istante in più (che solitamente alle casse non avete) scoprireste che le mentine potrebbero 
 La creatività, come abbiamo scritto più volte anche in questo blog, può essere una grande alleata in tempi di crisi occupazionale: inventarsi un lavoro, come si usa dire, a volte è l’unica strada veramente percorribile per chi cerca un’occupazione. Ma possiamo davvero inventarci un lavoro dal nulla? Veramente il nostro ingegno può essere ancora capace di trovare qualcosa che non esiste? Esiste ancora la possibilità di far nascere dal nulla qualcosa che prima non esisteva? Rispondere affermativamente a queste domande può essere al tempo stesso un bene o un male. Per rispondere potrebbe forse essere utile capire che cosa accade nel mondo delle invenzioni, quelle vere.
La creatività, come abbiamo scritto più volte anche in questo blog, può essere una grande alleata in tempi di crisi occupazionale: inventarsi un lavoro, come si usa dire, a volte è l’unica strada veramente percorribile per chi cerca un’occupazione. Ma possiamo davvero inventarci un lavoro dal nulla? Veramente il nostro ingegno può essere ancora capace di trovare qualcosa che non esiste? Esiste ancora la possibilità di far nascere dal nulla qualcosa che prima non esisteva? Rispondere affermativamente a queste domande può essere al tempo stesso un bene o un male. Per rispondere potrebbe forse essere utile capire che cosa accade nel mondo delle invenzioni, quelle vere.
 Chi di noi sta facendo un lavoro (trattasi di attività professionale remunerata, meglio ricordarlo di questi tempi) si sente spesso già fortunato da non mettersi anche a sindacare o discutere sul fatto che il lavoro gli piaccia o meno. Questo almeno per i primi mesi. Poi iniziano ad aumentare le grane, le cose che non vanno, i soldi che non bastano, le opportunità di crescita e carriera che scarseggiano e via discorrendo. Come dice a volte il comico Bertolino, il lavoro è quella cosa che lottiamo allo sfinimento per avere e che poi quando abbiamo non vediamo l’ora di lasciare. Insomma, i sentimenti che ci legano la lavoro che facciamo sono mutevoli e contradditori.
Chi di noi sta facendo un lavoro (trattasi di attività professionale remunerata, meglio ricordarlo di questi tempi) si sente spesso già fortunato da non mettersi anche a sindacare o discutere sul fatto che il lavoro gli piaccia o meno. Questo almeno per i primi mesi. Poi iniziano ad aumentare le grane, le cose che non vanno, i soldi che non bastano, le opportunità di crescita e carriera che scarseggiano e via discorrendo. Come dice a volte il comico Bertolino, il lavoro è quella cosa che lottiamo allo sfinimento per avere e che poi quando abbiamo non vediamo l’ora di lasciare. Insomma, i sentimenti che ci legano la lavoro che facciamo sono mutevoli e contradditori.


 C’è un tema sotteso a tutto quello che scorre sul web: il tema delle
C’è un tema sotteso a tutto quello che scorre sul web: il tema delle 


 Tra qualche ora molti di noi probabilmente, come da tradizione, scarteranno e poi romperanno con una certa bramosia l’uovo pasquale alla ricerca della sorpresa. Qualcosa di nascosto che però sappiamo ci farà piacere trovare all’improvviso. Anche se sarà una stupidaggine o una cosa poco utile: all’inizio il gusto sta solo nel vedere che c’è, nella curiosità. Questa piccola o altre grandi sorprese che funzione hanno nella nostra esperienza? Sono utili, funzionali a qualcosa o semplicemente è un modo per tenere allegro il clima?
Tra qualche ora molti di noi probabilmente, come da tradizione, scarteranno e poi romperanno con una certa bramosia l’uovo pasquale alla ricerca della sorpresa. Qualcosa di nascosto che però sappiamo ci farà piacere trovare all’improvviso. Anche se sarà una stupidaggine o una cosa poco utile: all’inizio il gusto sta solo nel vedere che c’è, nella curiosità. Questa piccola o altre grandi sorprese che funzione hanno nella nostra esperienza? Sono utili, funzionali a qualcosa o semplicemente è un modo per tenere allegro il clima?
 Se tra chi legge questo blog c’è qualcuno esperto o amante di storia forse ha già capito dove vogliamo andare a parare. Sicuramente saprà che cosa si intende per
Se tra chi legge questo blog c’è qualcuno esperto o amante di storia forse ha già capito dove vogliamo andare a parare. Sicuramente saprà che cosa si intende per 
 Sarà poi così vero che i giovani e soprattutto i nativi digitali (tra l’altro: siamo sicuri che vogliamo continuare a chiamarli così?) non si informano, quindi non si interessano, ergo non partecipano e non hanno a cuore la vita di una comunità più ampia che non quella fatta da se stessi e dai loro amici su Facebook? Non crediamo che sia poi così vero. In realtà, ce lo dice tra gli altri un
Sarà poi così vero che i giovani e soprattutto i nativi digitali (tra l’altro: siamo sicuri che vogliamo continuare a chiamarli così?) non si informano, quindi non si interessano, ergo non partecipano e non hanno a cuore la vita di una comunità più ampia che non quella fatta da se stessi e dai loro amici su Facebook? Non crediamo che sia poi così vero. In realtà, ce lo dice tra gli altri un 
 Quando cerchiamo lavoro sono molte le cose a cui dobbiamo fare attenzione: la redazione di un buon cv, una strategia attenta e curata per la scelta del nostro obiettivo professionale, la costruzione di una rete di contatti che possa essere costruttiva ed efficace ed infine una nostra presentazione complessiva che sia performante. Che cosa intendiamo per presentazione e come riusciamo ad ottenere questo risultato?
Quando cerchiamo lavoro sono molte le cose a cui dobbiamo fare attenzione: la redazione di un buon cv, una strategia attenta e curata per la scelta del nostro obiettivo professionale, la costruzione di una rete di contatti che possa essere costruttiva ed efficace ed infine una nostra presentazione complessiva che sia performante. Che cosa intendiamo per presentazione e come riusciamo ad ottenere questo risultato?
 C’è una questione legata al nostro modo di vivere nell’era digitale: la questione si chiama privacy. Senza che ce ne accorgiamo (forse) stiamo mano a mano, con il passare del tempo, regalando pezzetti della nostra vita e importanti informazioni su di noi ad aziende più o meno grandi. La leva con la quale siamo così disponibili a concedere informazioni che ci riguardano sono servizi che noi possiamo utilizzare; solitamente sono servizi gratuiti che un tempo nemmeno ci saremmo immaginati che qualcuno potesse concederci. Nell’era digitale a spiarci o a cercare di fare soldi con le nostre informazioni sono anche le smart TV, o le automobili futuristiche; in futuro ogni dispositivo avrà infatti la capacità di ascoltare le nostre conversazioni e fare ricerca dati in tempo reale. La privacy, che un tempo era un diritto, ora non è più nemmeno una buona condotta.
C’è una questione legata al nostro modo di vivere nell’era digitale: la questione si chiama privacy. Senza che ce ne accorgiamo (forse) stiamo mano a mano, con il passare del tempo, regalando pezzetti della nostra vita e importanti informazioni su di noi ad aziende più o meno grandi. La leva con la quale siamo così disponibili a concedere informazioni che ci riguardano sono servizi che noi possiamo utilizzare; solitamente sono servizi gratuiti che un tempo nemmeno ci saremmo immaginati che qualcuno potesse concederci. Nell’era digitale a spiarci o a cercare di fare soldi con le nostre informazioni sono anche le smart TV, o le automobili futuristiche; in futuro ogni dispositivo avrà infatti la capacità di ascoltare le nostre conversazioni e fare ricerca dati in tempo reale. La privacy, che un tempo era un diritto, ora non è più nemmeno una buona condotta.
 Avete mai avuto voglia di “perle di saggezza”‘ Qualche volta capita, no? Per esempio quando ci capita qualcosa che non capiamo oppure quando ci siamo sentiti stupidi davanti a qualche situazione. Ecco oggi, grazie anche all’
Avete mai avuto voglia di “perle di saggezza”‘ Qualche volta capita, no? Per esempio quando ci capita qualcosa che non capiamo oppure quando ci siamo sentiti stupidi davanti a qualche situazione. Ecco oggi, grazie anche all’
 Dimmi che contratto hai e ti dirò chi sei! Questo è un modo di dire che possiamo utilizzare per raccontare in qualche maniera la complessità e la varietà di contratti di lavoro che ci sono nel nostro sistema di regole. Quanti contratti di lavoro ci sono e come sono utilizzati? Premesso che una risposta totalmente esaustiva è difficile da dare in un post di un blog, proviamo comunque a tratteggiare una panoramica che speriamo possa essere utile ad orientarsi meglio.
Dimmi che contratto hai e ti dirò chi sei! Questo è un modo di dire che possiamo utilizzare per raccontare in qualche maniera la complessità e la varietà di contratti di lavoro che ci sono nel nostro sistema di regole. Quanti contratti di lavoro ci sono e come sono utilizzati? Premesso che una risposta totalmente esaustiva è difficile da dare in un post di un blog, proviamo comunque a tratteggiare una panoramica che speriamo possa essere utile ad orientarsi meglio.
 Ben ritrovati a tutti voi! Il nostro blog è stato fermo una settimana: stiamo facendo degli esprimenti per testare novità che speriamo di potervi presentare presto ;-). Ripartiamo di slancio e questa settimana cominciamo subito a parlare di lavoro e di come fare per trovarlo. Oggi proviamo a darvi qualche consiglio su come scrivere una lettera di accompagnamento. solitamente su questo documento ci si concentra poco (a torto) pensando che siano sufficienti “due righe” per accompagnare il cv scritte in maniera più o meno plausibile. Invece non è così: la lettera di accompagnamento, le “due righe” scritte nel testo della mail in cui allegate il cv sono il primo biglietto da visita che mostrate a chi non vi conosce. E spesso sono fondamentali. Partiamo dal’inizio. Innanzitutto, mail o lettera che sia, va indirizzata se possibile a qualcuno, meglio se una persona fisica (quindi nome e cognome e non solo il ruolo); e meglio ancora se la persona è quella che si occupa di personale in quell’azienda. Nel rivolgervi al vostro destinatario evitate troppe formalità ma iniziate sempre con un saluto e cercate di essere abbastanza cordiali (un “Gentile…” può andare bene). Evitate se possibile di iniziare con un generico “Spettabile azienda” o un “voi” generalizzato che non ottiene lo stesso grado di attenzione di un incipit maggiormente personalizzato. Se non avete idea della struttura che la lettera può avere, se non sapete da dove iniziare e come terminare la lettera un format molto semplice che ci sentiamo di consigliarvi è quello che abbiamo chiamato dei “3 perché”. Lo abbiamo chiamato così dal momento che una possibilità che avete di strutturare la lettera di accompagnamento è quella di rispondere idealmente a tre perché. Il primo “perché” riguarda voi stessi: perché siete voi? Quali sono le motivazioni che vi hanno portato ad affrontare un certo percorso formativo o una certa carriera professionale? Provate ad illustrare il vostro profilo professionale non tanto con l’elenco di titoli od esperienze (quelli si vedono sul cv!) ma dando qualche spunto sui motivi per i quali avete scelto una certa direzione professioanle. Il secondo perché riguarda invece la professione per la quale vi candidate: perché volete ricoprire quell’incarico? Cosa vi spinge a pensare che sapreste svolgere bene quel lavoro? Cosa potrebbe essere determinante, tra le vostre competenze, per il buon raggiungimento degli obiettivi che quella professione prevede? Cercate in poche righe di descrivere il valore aggiunto che esprimete e i bisognid ell’azienda che volete e potete soddisfare. Il terzo perché riguarda invece proprio l’azienda/organizzazione destinataria della vostra candidatura: perché avete scritto a quell’azienda? Cosa vi spinge a preferirla ad altri suoi competitor? Cosa ha in comune con voi rispetto a progetti, filosofia aziendale, vision? Dovreste riuscire a mettere in piedi in due righe almeno una buona motivazione in questo senso che possa ottenere due effetti: far capire che non state scrivendo la stessa lettera di presentazione all’ennesima azienda e testimoniare il vostro apprezzamento per il loro lavoro (i complimenti, a patto che siano sinceri, sono sempre apprezzati). Se riuscite a rispondere a ciascuna di queste domande con un breve paragrafo che non contenga errori grammaticali né di battitura avrete tra le mani una lettera di presentazione che può essere utilizzata con profitto. Non sarà una formalità sbrigata ma una vera e propria presentazione di voi stessi. Rileggetela, integratela e modificatela in modo che possa piacervi. Come dicono bene nel blog
Ben ritrovati a tutti voi! Il nostro blog è stato fermo una settimana: stiamo facendo degli esprimenti per testare novità che speriamo di potervi presentare presto ;-). Ripartiamo di slancio e questa settimana cominciamo subito a parlare di lavoro e di come fare per trovarlo. Oggi proviamo a darvi qualche consiglio su come scrivere una lettera di accompagnamento. solitamente su questo documento ci si concentra poco (a torto) pensando che siano sufficienti “due righe” per accompagnare il cv scritte in maniera più o meno plausibile. Invece non è così: la lettera di accompagnamento, le “due righe” scritte nel testo della mail in cui allegate il cv sono il primo biglietto da visita che mostrate a chi non vi conosce. E spesso sono fondamentali. Partiamo dal’inizio. Innanzitutto, mail o lettera che sia, va indirizzata se possibile a qualcuno, meglio se una persona fisica (quindi nome e cognome e non solo il ruolo); e meglio ancora se la persona è quella che si occupa di personale in quell’azienda. Nel rivolgervi al vostro destinatario evitate troppe formalità ma iniziate sempre con un saluto e cercate di essere abbastanza cordiali (un “Gentile…” può andare bene). Evitate se possibile di iniziare con un generico “Spettabile azienda” o un “voi” generalizzato che non ottiene lo stesso grado di attenzione di un incipit maggiormente personalizzato. Se non avete idea della struttura che la lettera può avere, se non sapete da dove iniziare e come terminare la lettera un format molto semplice che ci sentiamo di consigliarvi è quello che abbiamo chiamato dei “3 perché”. Lo abbiamo chiamato così dal momento che una possibilità che avete di strutturare la lettera di accompagnamento è quella di rispondere idealmente a tre perché. Il primo “perché” riguarda voi stessi: perché siete voi? Quali sono le motivazioni che vi hanno portato ad affrontare un certo percorso formativo o una certa carriera professionale? Provate ad illustrare il vostro profilo professionale non tanto con l’elenco di titoli od esperienze (quelli si vedono sul cv!) ma dando qualche spunto sui motivi per i quali avete scelto una certa direzione professioanle. Il secondo perché riguarda invece la professione per la quale vi candidate: perché volete ricoprire quell’incarico? Cosa vi spinge a pensare che sapreste svolgere bene quel lavoro? Cosa potrebbe essere determinante, tra le vostre competenze, per il buon raggiungimento degli obiettivi che quella professione prevede? Cercate in poche righe di descrivere il valore aggiunto che esprimete e i bisognid ell’azienda che volete e potete soddisfare. Il terzo perché riguarda invece proprio l’azienda/organizzazione destinataria della vostra candidatura: perché avete scritto a quell’azienda? Cosa vi spinge a preferirla ad altri suoi competitor? Cosa ha in comune con voi rispetto a progetti, filosofia aziendale, vision? Dovreste riuscire a mettere in piedi in due righe almeno una buona motivazione in questo senso che possa ottenere due effetti: far capire che non state scrivendo la stessa lettera di presentazione all’ennesima azienda e testimoniare il vostro apprezzamento per il loro lavoro (i complimenti, a patto che siano sinceri, sono sempre apprezzati). Se riuscite a rispondere a ciascuna di queste domande con un breve paragrafo che non contenga errori grammaticali né di battitura avrete tra le mani una lettera di presentazione che può essere utilizzata con profitto. Non sarà una formalità sbrigata ma una vera e propria presentazione di voi stessi. Rileggetela, integratela e modificatela in modo che possa piacervi. Come dicono bene nel blog 