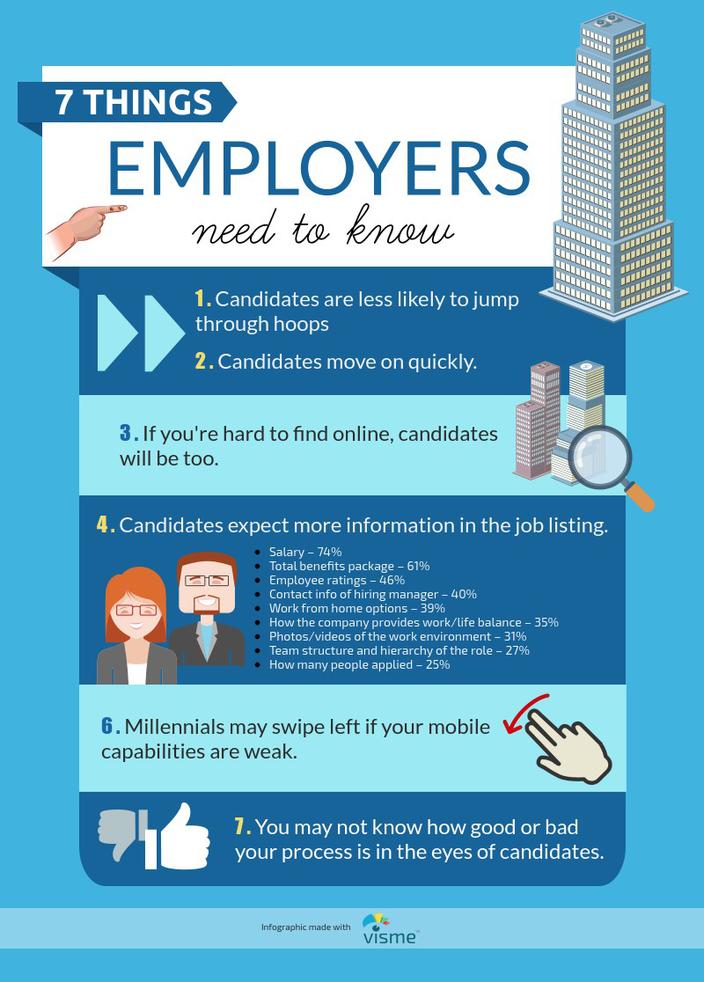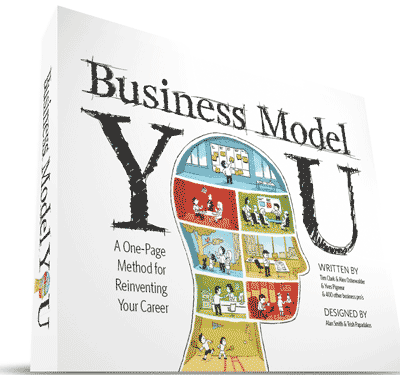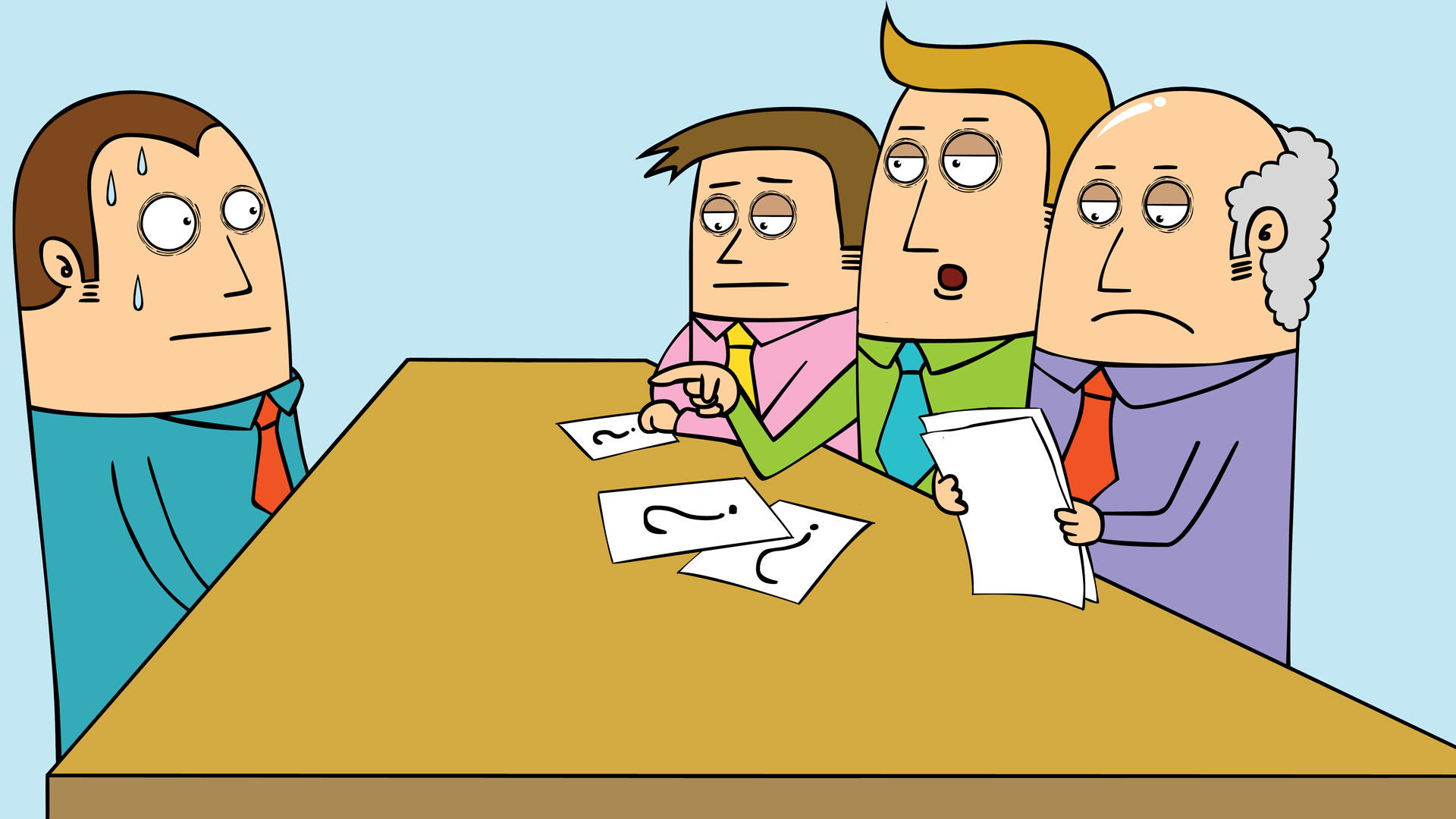Quanto è importante condividere? Secondo una canzone che sta tormentando la nostra estate, è più importante che vivere. Ma senza essere così iperbolici, possiamo affermare che anche (o soprattutto?) nel mondo del lavoro di oggi, il successo vero arriva quando si è in grado di formare una rete di contatti, di competenze, di idee in grado di produrre un enorme valore aggiunto a tutto ciò che stiamo creando.
Chi fa coworking lo sa bene, pure se la definizione di questa tipologia di lavoro è, a primo impatto, piuttosto sterile: Wikipedia infatti ci spiega che “Il coworking è uno stile lavorativo che coinvolge la condivisione di un ambiente di lavoro, spesso un ufficio, mantenendo un’attività indipendente. A differenza del tipico ambiente d’ufficio, coloro che fanno coworking non sono in genere impiegati nella stessa organizzazione“.
Il coworking, la cui traduzione letterale è “lavorare insieme”, ha in realtà una duplice funzione: da un lato la fornitura di spazi “chiavi in mano” in cui un professionista o aspirante tale che non può permettersi un ufficio può trovare, in genere a costi piuttosto accessibili, un luogo creato sempre più ad arte e fornito di tutti i comfort (computer, wi-fi, telefono e fax, ma anche aree relax e postazioni open space per tenere riunioni) dall’altro, ed è qui la sua maggiore utilità, è una vera fucina di idee, un luogo in cui l’incontro di menti, esperienze e competenze anche piuttosto diverse tra loro può fiorire e dare il suo meglio.
In barba alla definizione semplicistica di Wikipedia, in non molto tempo le reali potenzialità di questo nuovo stile lavorativo sono saltate agli occhi delle grandi aziende, in primis a quelli delle multinazionali statunitensi, ben disposte ad ospitare in propri spazi debitamente allestiti menti creative e giovani imprenditori, così da “nutrirsi” – nel senso più positivo del termine, ovviamente – delle loro idee e prospettive, praticando il cosiddetto “coworking verticale“, formato da professionisti che operano nello stesso settore (al contrario del “coworking orizzontale“, che si sviluppa invece sul lavoro di persone impiegate in ambiti diversi).
Ma senza scomodare le grandi imprese d’oltreoceano si possono scoprire, con una semplice ricerca Google, numerosi esempi di realtà italiane nate appositamente per favorire il lavoro condiviso: c’è chi cerca di riunire le realtà di coworking sotto uno standard e chi offre consulenza e sostegno per l’allestimento di spazi di coworking all’interno di realtà professionali con ambienti inutilizzati, ma anche chi fonda, sui valori della condivisione del lavoro e delle idee, associazioni no-profit.
Facendo un passo indietro, chi ha “creato” il coworking? É importante premettere che, citando l’intervista all’avvocato Domenico Comito per la Wind Buisness Factory: ” Il coworking spesso è istituito da una cd comunità di coworking, ove vengono condivisi i medesimi obiettivi e/o affini modalità di gestione del lavoro”, a dimostrazione ulteriore del fatto che la condivisione semplicemente fisica di uno spazio di lavoro per “dividere i costi d’affitto” conta poco o nulla.
La prima realtà di coworking nasce negli USA nel 2005, su iniziativa di Brad Neuberg, un programmatore di San Francisco a cui serviva un posto in cui riunirsi con il suo gruppo di lavoro che non fosse l’ormai abusato bar. Poco dopo si fecero strada tentativi più articolati e sempre più diffusi, negli Stati Uniti e altrove, fino a quando anche l’Italia, nel 2008, “si incontra” con il coworking, dapprima nelle principali metropoli e poi in tutto il resto della penisola (Marche comprese! Provate a cercare e resterete sorpresi. Noi nel frattempo vi suggeriamo due realtà nelle nostre vicinanze: Cowo Coworking Ancona e Cowo42). Ad oggi, anche se è piuttosto complicato determinarne con precisione il numero, si conoscono più di 300 realtà di coworking in Italia.
Anche se è passato qualche anno, una buona parte di chi pratica questo stile lavorativo ha ancora lo stesso profilo professionale degli albori: meno di trenta anni e specializzazione nell’ambito dell’informatica, del web design e della comunicazione. La giovane età e una professione che più di altre si presta alla necessità di “fare rete” sono caratteristiche che hanno favorito questa concezione di lavoro fuori da quella classica di ufficio, anche se sono sempre di più i professionisti di altri settori interessati a prendere il meglio dall’autonomia imprenditoriale e dalla condivisione del lavoro e delle competenze.
Nel mondo odierno, frutto di una società liquida in cui trovare il proprio posto di lavoro (non solo materialmente parlando) è sempre più complesso e meno scontato, in cui crearsi una rete di contatti e collaborazioni è ben più importante che nel passato, la possibilità di costruire la propria identità professionale in luoghi di costante confronto vivo e creativo è un’opportunità da non perdere, soprattutto se si è dei giovani bisognosi di accrescere le proprie competenze ed entusiasti di dare forma a quello che, secondo molti, è il futuro del lavoro.
All’ Informagiovani lo sappiamo bene, per questo vi ricordiamo che i nostri spazi, oltre a poter essere affittati per riunioni e conferenze, si possono utilizzare, mentre siamo aperti, come aula di studio, luogo per incontrarsi e perché no, “cantiere” per far nascere progetti in condivisione e dare vita a collaborazioni di tutti i tipi. Vi aspettiamo nei nostri orari di apertura!