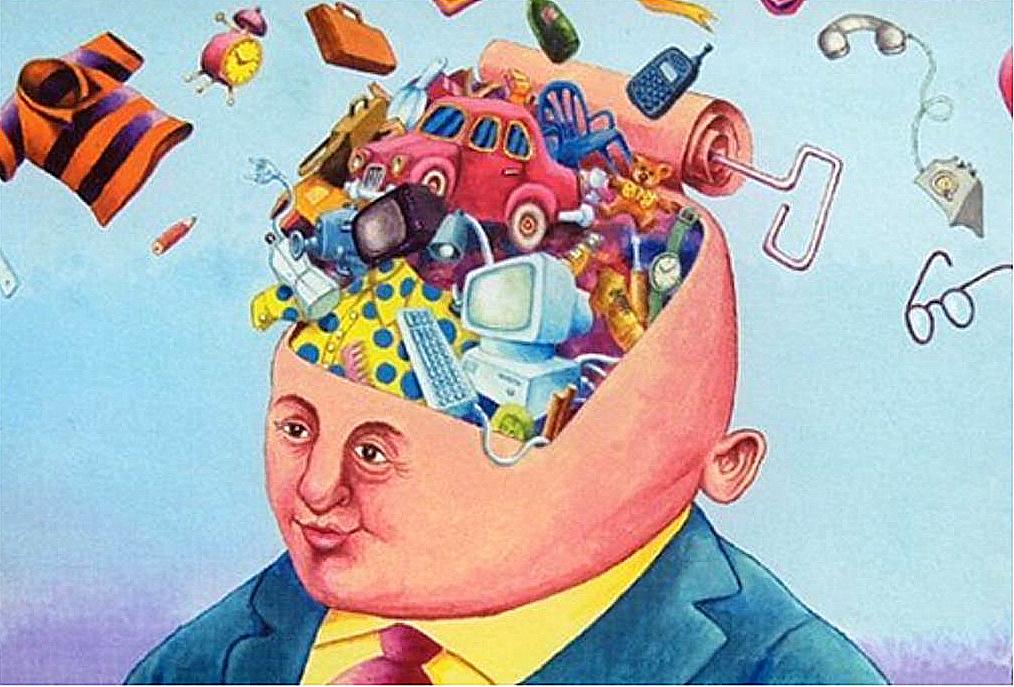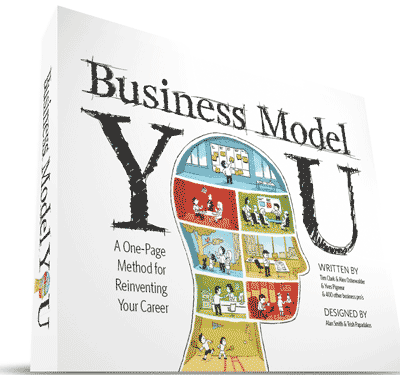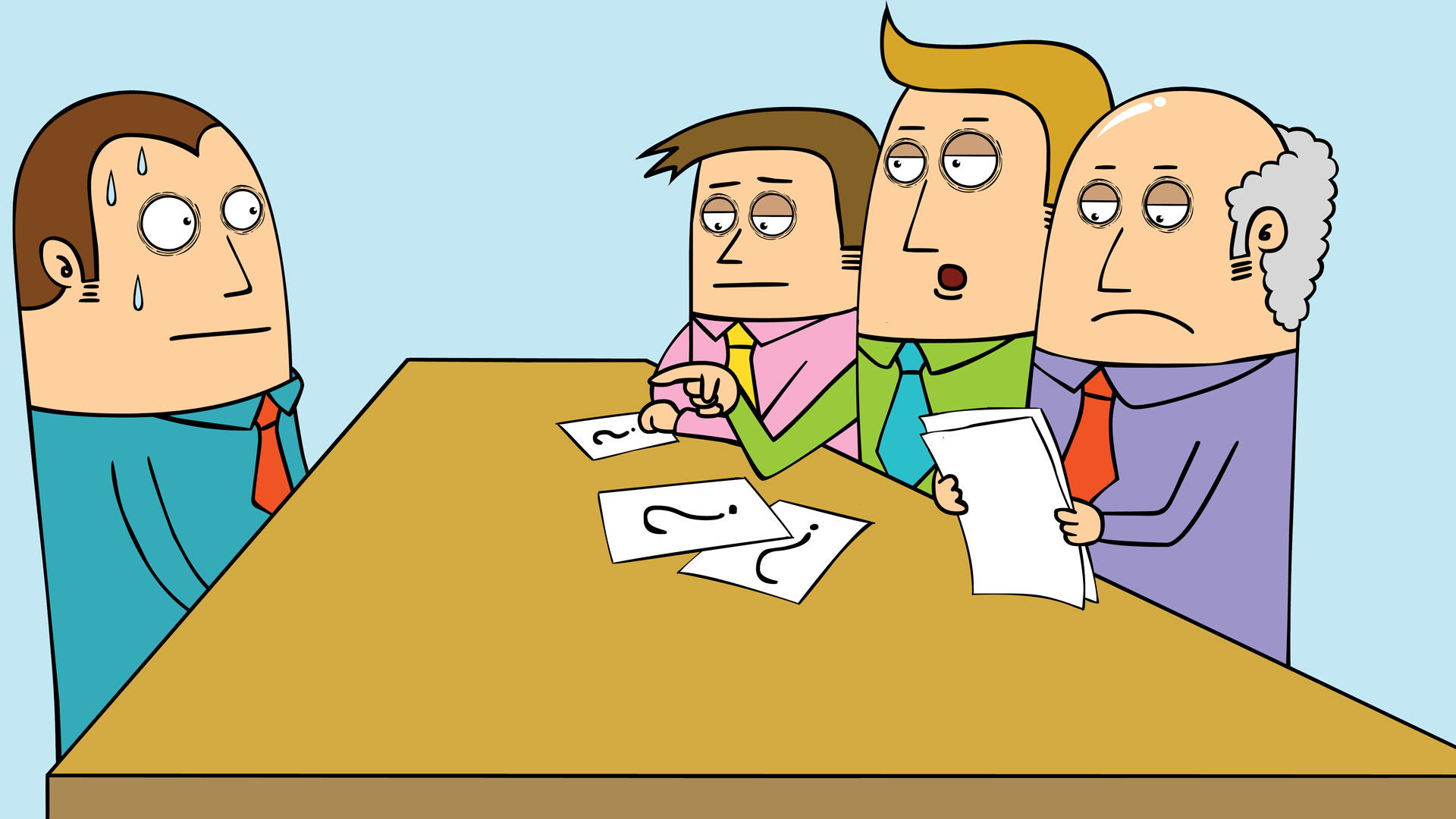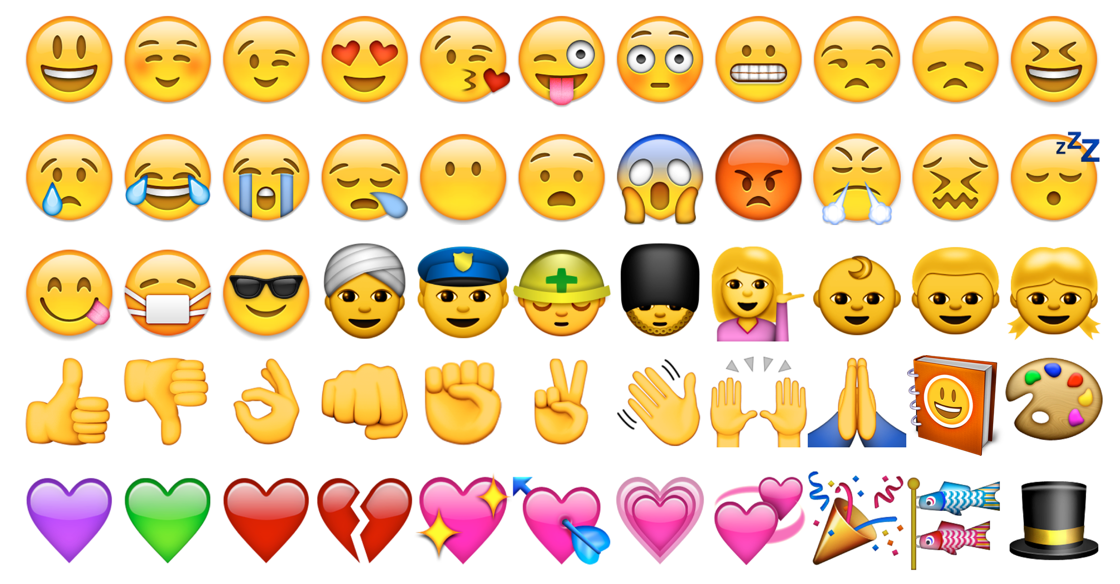Come prendiamo le nostre decisioni?
Come mai alcune persone decidono di diventare imprenditori e altre no? Perché preferiamo rimandare (decisioni, lavori, impegni) piuttosto che fare quel che occorre? Come reagiscono le persone davanti a una perdita o a un guadagno? Cosa motiva in generale le persone? Come prendiamo le nostre decisioni? A queste domande e ad altre ancora cerca di rispondere una recente disciplina, chiamata neuroeconomia.
Il termine neuroeconomia deriva dall’unione di due discipline che possono sembrare distanti tra loro: la prima indica lo studio del cervello, del sistema nervoso e di come influenza ed è influenzato dall’ambiente che lo circonda. La seconda, invece, studia come due soggetti interagiscono tra loro, attraverso scelte più o meno razionali, utilizzando le risorse che possiedono o sono presenti nel loro ambiente.
L’obiettivo della neuroeconomia è capire come si comporta il cervello durante i processi di decisione. In particolare in quelli di decision making, quando nella scelta sono implicati fgattori economici: dalla semplice spesa in un supermercato, all’acquisto o vendita di un titolo azionario. Modi di agire che in linea di principio sono legati alla sfera economica, ma che effettivamente derivano da comportamenti spcifici del nostro cervello.
Questa disciplina si basa su strumenti, ormai sempre più diffusi, come il PET (Tomografia ad emissione di positroni https://it.wikipedia.org/wiki/Tomografia_a_emissione_di_positroni), la risonanza magnetica e altri strumenti di indagine del nostro cervello che permettono di capire come reagisce agli impulsi esterni.
Per esempio, sono stati realizzati alcuni studi su trader professionisti e sulle emozioni che si scatenano durante le operazioni di borsa. È stato osservato che nei momenti cruciali delle decisioni si attivano nelle menti degli operatori due dinamiche di pensiero: quella emozionale e quella razionale. Spesso è la prima a predominare sulla seconda. Attraverso questi studi risulta chiaro che l’ansia è maggiore quando le variabili esterne sono impreviste. Prendere decisioni è sempre stata considerata un’attività razionale e consapevole, in cui l’individuo che decide agisce esclusivamente in base alla massimizzazione del proprio interesse. La neuroeconomia attraverso studi e ricerche mette questa convinzione in discussione, fornendo prova che nel momento in cui si prendono delle decisioni hanno molta importanza le esperienze, le emozioni e i processi mentali involontari.
Quante volte siete andati in ansia per una scelta difficile? Quante volte abbiamo pensato di fare la scelta sbagliata? Non preoccupatevi, rilassatevi: la neuroeconomia ci insegna che per quanti sforzi possiamo fare la nostra scelta non sarà mai perfettamente razionale.
(questo articolo è stato scritto da Ilaria Carrasso)