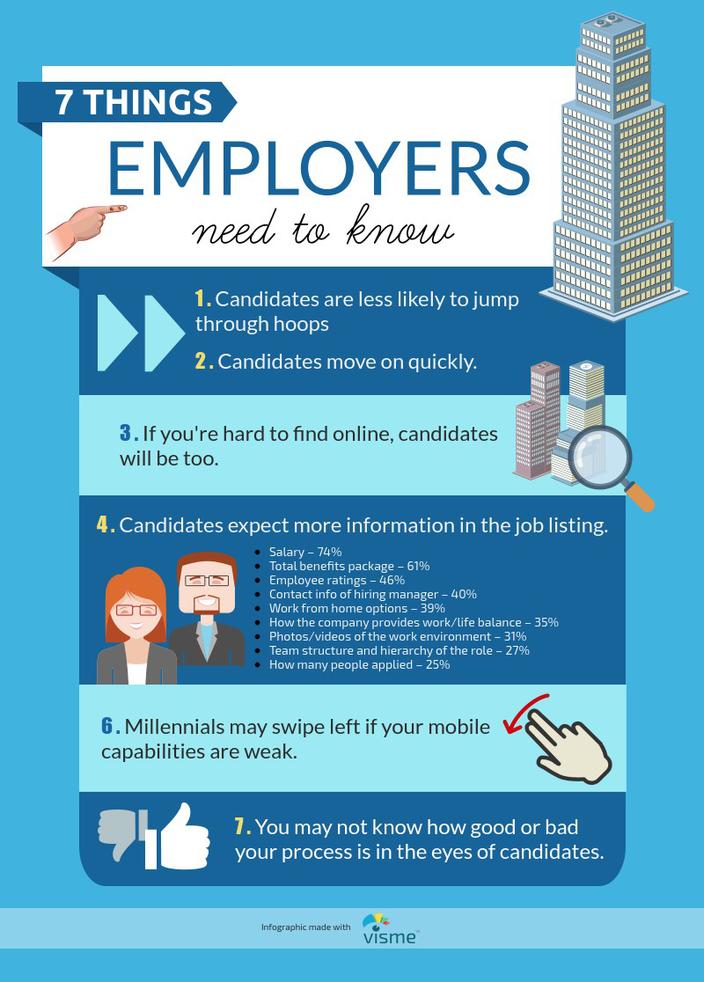Il prossimo 9 giugno torneremo a parlare di immagini, fotografia e di come queste possono diventare un potente strumento per rappresentare le proprie emozioni. Lo faremo ospitano Emanuele Maggini, fotografo anconetano che ha realizzato un interessante progetto con il carcere. In anteprima sul nostro blog un’intervista che gli abbiamo fatto per capire meglio che cosa è successo.
Il tuo progetto ha portato la fotografia in carcere: ci spieghi meglio di cosa si è trattato?
La mia esigenza in quanto fotografo è sempre stata quella di trasmettere sensazioni ed emozioni,con la fotografia si ha la possibilità di rendere tangibile ciò che abbiamo dentro. Ho sempre desiderato fare qualcosa di buono per gli altri con la mia passione e con il mio lavoro,quindi ho deciso di portare la fotografia in un contesto molto particolare,in un contesto,ovvero il carcere, dove la fotografia è totalmente assente. È stata una sfida anche con me stesso che poi ha portato a risultati eccezionali anche grazie alla presenza costante di mia sorella Alice dottoressa in scende e tecniche psicologiche che ha dato un contributo enorme alla realizzazione di questo progetto. Si è trattato di uno corso settimanale con lezioni di due ore, dove è stata insegnata l’importanza della fotografia come mezzo di comunicazione in tutti i suoi aspetti ( racconto autobiografico, mezzo pubblicitario e come portavoce di contenuti inconsci) il tutto accompagnato da slide con esempi di fotografie tipo. Si è poi proseguito con l’insegnare la tecnica base della fotografia (tempi, diaframma, regola dei terzi, luci). Tutto quello che è stato imparato al corso i detenuti lo hanno messo in pratica, realizzando foto da loro progettate che potessero esprimere i loro contenuti.
Come mai hai pensato alla realtà carceraria? Nella tua percezione che tipo di stimolo,valore poteva avere la fotografia in quel contesto?
La mia esperienza personale e professionale mi ha portato alla consapevolezza di quanto la fotografia possa essere un potente mezzo per poter comunicare molto più di quanto possa essere detto. Ha il potere di poter esprimere contenuti scomodi e dolorosi di chi fotografa con eleganza e meno sofferenza e al tempo stesso la capacità di richiamare emozioni proprie in chi la guarda. Ho così pensato che potesse essere un valido sostegno farla entrare nella realtà carceraria. E che potesse offrire un valido ponte per tirare fuori l emotività di un utenza che ero sicuro avesse molto da comunicare e che poi potesse riavvicinare la comunità libera alla penitenziaria, avvolte questi due mondi sono così distanziati da stereotipi e pregiudizi che creano le vere sbarre della reclusione. Va aggiunto che secondo la costituzione il carcere è un sistema rieducativo e non mi dispiace l’idea che dopo questo corso teorico e pratico al quale ho rilasciato anche un attestato, finita la detenzione, qualcuno decidesse di fare buon uso di questa esperienza, appassionarsi a questa arte, così da farne un lavoro a tutti gli effetti.
Come è stato accolto dai detenuti il tuo arrivo? E la tua proposta?
La prima lezione è stata una di quelle più particolari, si avvertiva l’emozione ambo le parti, da parte mia sebbene avessi già sostenuto corsi importanti entrare nel contesto carcerario mi dava un mix di alte aspettative e paura, i ragazzi dall’altra parte erano incuriositi da questo corso innovativo mai fatto prima non avevano mai affrontato la fotografia in un contesto carcerario,alcuni di loro prima, e non sapevano cosa aspettarsi, abbiamo da subito appreso che il sistema detentivo lascia poco spazio alla comunicazione e che si erano iscritti a questo corso alla ceca senza sapere di cosa so trattasse ne con che modalità, hanno quindi iniziato a riempirci di domande e questo a facilitato il momento della presentazione, da lì in poi abbiamo instaurato immediatamente un bellissimo rapporto insegnantei-alunni che ci ha portato a collaborare in maniera eccezionale e professionale.
La fotografia nel tuo caso è stata un’esperienza artistica più che tecnica: possiamo dire che l’arte riesce a liberare le persone? In questo caso non hai corso il rischio di acuire ancor più il senso di libertà? Se ce stato questo rischio come lo avete superato?
La parte tecnica è stata fondamentale nell’insegnare a loro come poter utilizzare questo mezzo di comunicazione in maniera idonea, poi effettivamente la parte artistica è stata prevalente e molto più stimolante dato che il fine principe del progetto era di tirare fuori emozioni ed imprimerle in uno scatto. Il percorso per creare una foto è: concentrarsi su un pensiero, riflettere a fondo su di esso e imprimerlo. Progettando il corso io ed Alice abbiamo più volte riflettuto sul pericolo effettivamente di acuire il senso di perdita della libertà e abbiamo fatto molta attenzione ad usare immagini e parole che limitassero quanto più possibile questo pericolo. Ma l’arte è sinonimo di libertà di pensiero non fisica, e offrire loro un percorso che potesse restituirgli un po’ della loro individualità persa con l’entrata in carcere e la possibilità di comunicare anche contenuti indicibili è stata una cosa molto apprezzata dai detenuti. Abbiamo da subito compreso che la vera condanna non è la reclusione fisica ma lo smarrimento della propria personalità. Esistono celle di ferro ma anche delle prigioni mentali, l’offrire l opportunità di tirare fuori quello che avevo dentro dentro positivo o negativo, e poterlo raccontare oltre le mura, li ha secondo me per una frazione di secondo resi, veramente liberi.
In questo percorso sei stato coadiuvato da un dottoressa in scienze e tecniche psicologiche: quale è stato il suo contributo e quale, se possibile, la sua analisi dei risultati ottenuti?
Maggini Alice dottoressa in scienze e tecniche psicologiche ha contributo prettamente alla parte emotiva del corso. Il suo ruolo è stato finalizzato alla spiegazione della fotografia come veicolo di contenuti emotivi che in questo particolare contesto può rivelarsi strumento portavoce di sentimenti anche scomodi e dolorosi, ma che sono inevitabilmente presenti, anche se non detti, come anche di elementi positivi che esistono anche se si fatica a vederli in un contesto così duro e restrittivo. Portando poi i detenuti a far emergere questi sentimenti e individuando con il gruppo gli oggetti che potessero rappresentarli. Oggetti che poi sono stati utilizzati nel set e che i detenuti hanno utilizzato per le foto prodotte in still-life.
Alle luce di quanto emerso dalle foto prodotte la Dott.ssa Maggini Alice ritiene che l’ obiettivo del progetto sia stato raggiunto a pieno, considerando l’evolversi delle dinamiche di gruppo nelle varie fasi del progetto. Partito con un utenza che se pur ben disposta e pronta al dialogo è risulta nelle prime fasi palesemente in difficoltà a fermarsi su certi contenuti emotivi e non abituata a lavori che coinvolgono l’ emotività e che alla fine ha prodotto foto che raccontano di temi importanti come il rimorso, la solidarietà, la nostalgia e tanto altro. Particolarmente importante risulta il lavoro sul “tempo che scorre” tematica che come si può ben immaginare ha creato non poco disagio nel gruppo (utenza che nella maggioranza ha 10 e più anni di reclusione da scontare), argomento tanto fastidioso da essere considerato in prima istanza tabu e che alla fine del progetto risulta essere l’elemento principe della maggior parte delle foto.
Hai realizzato un corso di fotografia e quindi avevi un’aula anche se del tutto particolare; come è stato il rapporto umano con questi alunni? Cosa hai notato di diverso dalle altre aule.
Come ti dicevo prima,ho insegnato in molto corsi,con tantissimi partecipanti,non è stato poi cosi diverso a parte la presenza delle telecamere e le regole restrittive in cui ho dovuto giostrarmi. Ho trovato nell’utenza molta educazione e disciplina e soprattutto interessata e collaborativa, il rapporto è stato sempre insegnante-alunno come sempre faccio,in questo caso a maggior ragione ma ovviamente non sono mancate risate e momenti meno impegnativi dove poter scambiare due parole in tranquillità. Non sono mancati anche momenti di tensione soprattutto quando si è andati a toccare le emozioni che solitamente sono tenute al di fuori delle mura carcerarie e che come ci hanno più volte spiegato i detenuti se e quando emergono sono in questo contesto amplificate. Io e Alice ci siamo sempre concessi un momento di restituzione alla fine del corso dove io e lei discutevamo insieme su ciò che era emerso nella lezione, sui contenuti emotivi che ci portavamo via e su quale strategie adottare nella prossima lezione, siamo così riusciti a fronteggiare il tutto al meglio creando un bellissimo rapporto con la classe tanto che a fine corso per i saluti finali ci sono stati momenti toccanti conclusi con un arrivederci. I detenuti hanno pensato di salutarci scrivendoci delle lettere di ringraziamento da come ricordo per quanto abbiamo fatto insieme. È stata una cosa molto emozionante.
Ci puoi dire se questa esperienza ha cambiato il tuo modo di vedere la realtà carceraria e se si in quali termini?
Ho sempre pensato che il carcere debba essere rieducativo e non prettamente punitivo ,per molti di loro come ci hanno detto tramite lettere la punizione più grande è dentro di loro,quella di dover convivere con rimorsi e sensi di colpa. È stata un’esperienza molto intensa che mi ha portato a ragionare a fondo sulle conseguenze delle nostre azioni di tutti i giorni,sia piccole che grandi,sia positive che negative. Mi hanno fatto capire l’importanza della vista ,della libertà,della possibilità di scegliere,l’importanza di una carezza e il peso di uno schiaffo.
In che modo invece pensi possa essere stato utile per i detenuti?
Prima di tutto,la nostra presenza li ha stimolati a conoscersi, confrontarsi,a interagire con noi che venivamo da oltre le mura, hanno inoltre imparato un mestiere,che ovviamente in caso in un futuro lavoro come fotografo andrà rinforzato ma alcuni di loro hanno lasciato questa porta aperta per quando usciranno…e cosa più importante sono riusciti a tirar fuori ciò che avevano dentro con loro sorpresa,sono loro che hanno preso la reflex,calcolato la luce,creato il set e fatto lo scatto….creando delle vere e proprie opere che raccontano di loro. Secondo me sono stati straordinari.
Ci dici quali saranno i prossimi passi e come altre persone posso avvicinarsi a questa esperienza anche solo per conoscerla? E per conoscere i lavori fatti?
Certamente, abbiamo in previsione diverse mostre in tutte le Marche, partendo da Ancona ovviamente per poi fare altre tappe a Senigallia, Jesi ed altre città. Non saranno solamente mostre dove verranno esposte le foto dei detenuti ma faremo anche degli incontri aperti al pubblico dove io e Alice parleremo di questa straordinaria esperienza (l’appuntamento ad Ancona è per il 16 giugno nella sala dell’Informagiovani, in piazza Roma; ndr)
Che obiettivi può avere nel tuo futuro questa esperienza? Possiamo dire che ci sarà un continuo?
Una delle cose che ho capito ancor prima di iniziare il corso è che niente è impossibile,nonostante molti dicevano che non ci sarei riuscito per molte ragioni,quindi continuerò a portare avanti questo programma facendo altri corsi in tutta italia,ci hanno già contattato altri carceri per organizzare mostre,corsi ed incontri. Ho fatto della fotografia la mia disciplina,il mio stile di vita,ne ho ulteriore avuto conferma dell’importanza, quindi poterò sicuramente avanti altri progetti come questo. La cosa straordinaria è che questa esperienza ha formato loro quanto noi e vorrei ricordare che senza la disponibilità del Carcere di Montacuto,senza la determinazione e la voglia di cominciare dei detenuti con le loro stupende foto, tutto questo non sarebbe mai potuto accadere. Quindi ringraziamo tutti loro.
Vorremo infine ringraziarvi per questa bellissima intervista che ci avete fatto, per noi è stato importante il lavoro che abbiamo fatto dentro al carcere quanto riuscire a portarlo all’esterno, grazie ancora.